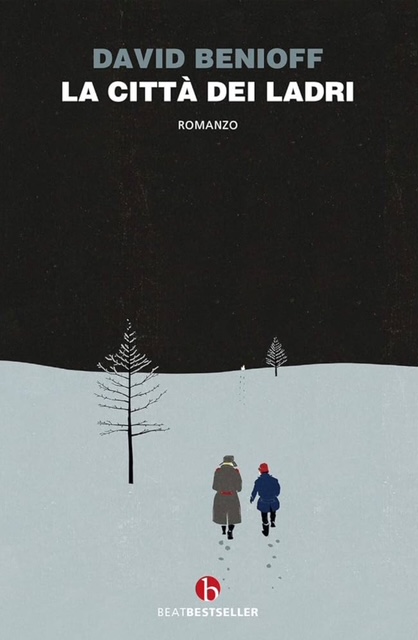
Ho appena finito di leggere Sangue marcio, esordio letterario di Antonio Manzini (2005) ripubblicato quest’anno da Piemme. Rocco Schiavone, venuto al mondo alcuni anni dopo questo esordio (2013), lo definirebbe un romanzo assai “trucido”. Durante la lettura mi sono fermato più volte, turbato dalla ruvidezza dei contenuti, esclamando, con le parole del vicequestore Schiavone: “eccheccazzo!”.
Poi ho letto un’intervista in cui Manzini confessa che oggi, a vent’anni da quell’esordio, non lo riscriverebbe tale e quale.
Richiesto di segnalare un romanzo da leggere, e qui arriviamo al motivo per cui scrivo questa pagina, Manzini ci fa un regalo: segnala La città dei ladri, di David Benioff (pseudonimo di David Friedman). Chissà, forse la segnalazione si deve a una vicinanza biografica tra i due autori, infatti Benioff come Manzini ha iniziato la sua carriera di scrittore come sceneggiatore, in particolare come adattatore per il cinema di testi letterari (alcuni dei quali scritti da lui, proprio come Manzini).
Sperando nella capacità di Manzini di segnalare buoni romanzi ho subito provato a cercare il romanzo di Benioff su MLOL (Media Library On Line), con poche speranze di trovarlo. Invece non solo era presente nel catalogo online, era anche libero per il prestito. Così, in men che non si dica, praticamente cinque minuti dopo aver letto l’intervista a Manzini, mi sono ritrovato con il romanzo La città dei ladri nel mio iPhone, pronto per essere letto.
Benioff, e non so se è una finzione letteraria o la semplice verità, nel prologo ci dice che tutta la storia è stata vissuta dal nonno che ha deciso di raccontargliela davanti a un audio-registratore per aiutarlo a scrivere una storia su Leningrado, dove era nato e cresciuto prima di emigrare negli USA. Il nonno racconta di sé, di un suo amico, dell’assedio nazista di Leningrado, di una dozzina di uova da trovare per evitare la morte sicura e di una giovane cecchina della resistenza russa (che poi diventerà la nonna di Benioff).
Non ho intenzione di parlare della storia, vera o finta che sia, ma delle sensazioni che ho provato davanti alla storia e ai suoi protagonisti. Sulla linea del tempo che copre la vita di tre generazioni io mi colloco sullo stesso piano della seconda, quella che è assente nella storia. Per capirci, non appartengo alla generazione del nonno che narra, né a quella del nipote che ascolta e registra. Io appartengo alla generazione di mezzo, cioè la generazione dei genitori del nipote che scrive e, allo stesso tempo, dei figli del nonno che racconta.
Alla fine della storia ho provato la sensazione di essere stato non a contatto ma in prossimità temporale con la storia e con la Storia. Sono nato 11 anni dopo la settimana in cui si svolge la storia narrata dal nonno di Benioff (la prima settimana del 1942) e nove anni dopo la fine dell’assedio di Leningrado (1944). Potrei essere figlio dell’io narrante che nel 1941 aveva 17 anni (un anno più di mio padre), così come potrei essere, anno più anno meno, padre di Benioff. Ciò che accade in una settimana al nonno di Benioff è un concentrato di vita vissuta al confine con la miseria, la morte e il male assoluto.
Sempre nel prologo Benioff afferma che in lui il desiderio di scrivere e di raccontare storie era molto forte ma che poiché la sua vita scorreva piana e senza eventi memorabili, che sono la materia prima per un narratore di storie, aveva deciso di ricorrere a quella parte della vita del nonno così movimentata e così piena di fatti da raccontare. Ci sono vite così piatte da non poter essere raccontate? Non lo credo. Il racconto in molti casi ricorre all’invenzione, alla creazione di altre realtà. Chissà, forse anche Benioff ha inventato la storia del nonno. E la sua vita non è così piatta, è uno sceneggiatore di successo, per dirne una: la penna del Trono di spade è sua.
Comunque, inventata o no la storia narrata ne La città dei ladri, è assolutamente verosimile. La generazione che ci ha preceduto ha vissuto esperienze grandi e terribili legate alla seconda guerra mondiale, noi abbiamo vissuto un lungo periodo di pace, se pace si può definire un periodo in cui sono state combattute molte piccole guerre in tutto il mondo (piccole, si intende, in confronto alla seconda guerra mondiale). La guerra in Medio Oriente ci sta facendo assistere, come spettatori inermi, ad atrocità che ricordano molto da vicino quelle della seconda guerra mondiale e il paradosso sta nel fatto che a rendersi responsabile di queste atrocità è il governo di un paese il cui popolo è stato la vittima delle più grandi atrocità della seconda guerra mondiale. Così come vittima dell’invasione nazista era stata l’Unione Sovietica (al centro del romanzo di Benioff), che oggi diventata Russia si è trasformata da paese invaso a paese invasore (la guerra in Ucraina è una delle tante guerre ancora in corso).
Tutto questo mi ricorda i versi de L’héautontimorouménos, di Baudelaire:
… Je suis la plaie et le couteau ! Je suis le soufflet et la joue ! Je suis les membres et la roue, Et la victime et le bourreau ! Je suis de mon cœur le vampire…
Ecco, la vittima e il carnefice, il vampiro del proprio cuore. Che in questo caso, pensando a ciò che accade quotidianamente a Gaza, è il cuore dolente del nostro Occidente. Che tristezza.

Lascia un commento